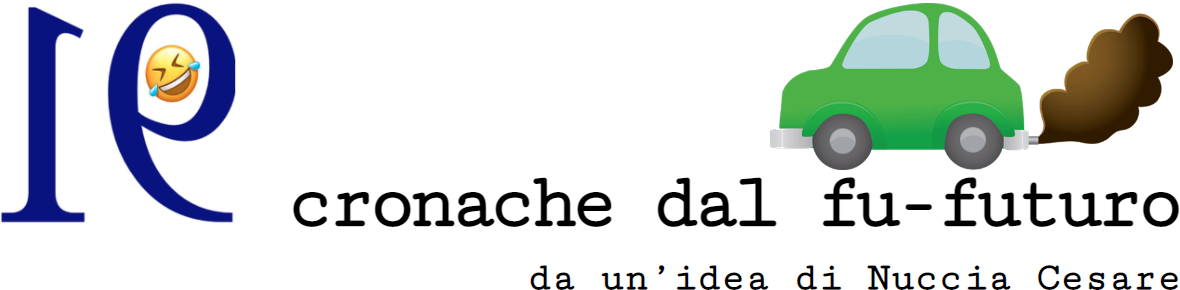Io ho visto “cose”…
Ho visto una teoria di corpi totalmente inermi. Volti vuoti, espressioni improbabili che sembravano un insulto. Ho abbassato gli occhi facendomi carico del loro pudore, non perché la loro vista mi impressionasse.
Ho ascoltato un silenzio innaturale, frequentato unicamente dai bip delle macchine e rotto solo dagli allarmi. Ho ascoltato i miei monologhi.
Ho visto medici e infermieri muoversi leggeri anche quando andavano di fretta, li ho sentiti parlare pacati, qualcuno canticchiava persino (è lavoro, bellezza!). In terapia intensiva ci si confronta con la morte, la situazione precipita in un istante. Si muore “inaspettatamente” nell’arco di pochi giorni o di poche settimane. Si sopravvive a dispetto di qualunque previsione resistendo per mesi, combattendo a mani nude, dal momento che le uniche risorse per lottare vengono bombardate da un’arma letale per loro: lo chiamano sistema immunitario, ed è una cosa molto più complessa di quel che si crede di conoscere. L’arma è il cortisone, perché c’è un livello superato il quale i Fiori di Bach non bastano più, anni di sedute psicanalitiche evaporano, la mindfulness è inefficace, lo yoga non aiuta, il cibo biologico non riesce più a proteggerti.
Succede. A volte le cose succedono e basta.
Fare una buona vita è una buona cosa in sé, ma ti deve anche andare di culo, forse hai dei buoni geni. Perché altrimenti i conti non tornano, a guardare altre vite.
Questa è una storia che andrebbe raccontata a più voci.
C’è chi l’ha vissuto e lo vive ancora sul proprio corpo: è stato beccato, dio sa come! Non se lo chiede più per stanchezza, non è più una “priorità”, ormai c’è dentro, e pace all’anima sua che invece è tutta presa dalle piccole cose che ti dicono “vivo”.
Quanti muscoli sono coinvolti per mangiare, quanti bisogna cooptarne per sfidare la forza di gravità e stare semplicemente in piedi, dove sono andate a finire le parole per chiamare le cose, qual è il nome delle cose che non sono cose ma che pure hanno un corpo? Dov’è la voce? Quella voce, la sua voce?
Perché mi danno tutti del tu, perché mi trattano come un deficiente, perché me la raccontano e perché non me la raccontano, perché si comportano come se avessero a che fare con pezzi di corpo?
Come si passano 24 ore quando sei finalmente tornato presente a te stesso? Cosa vuoi sentirti dire e come vuoi sentirtelo dire? Cosa non vuoi proprio sentirti dire?
Poi c’è chi è stato seduto per mesi sull’orlo dell’abisso. Che ha cercato un tratto familiare in quel volto allucinato. Che tutte queste cose (quelle di cui sopra), se le è solo immaginate. “Ecco, adesso faccio finta di essere nel letto al suo posto ma con tutta la mia consapevolezza: che cos’è che vedo?, che cosa mi arriva da fuori e come?” Immaginazione, pura immaginazione. Finché non te lo racconterà lui, quando troverà le parole.
Perché non sempre si ha l’energia di parlare da soli, perché di argomenti non è hai più e io (io) proprio non ce la faccio a ripetermi, non se so che una cosa l’ho già detta, e allora un modo per passare il tempo devi trovartelo. Allora provi a cantare, piano (chissà se sente con due mascherine e una visiera?). Lo tocchi (chissà che sente con due paia di guanti, anche perché io trovo solo ossa). Stai in silenzio e basta (cosa che ti riesce meglio se qualcuno si ricorda di portarti una sedia). Leggi i numeri sul monitor, capisci niente ma ha il suo fascino. Segui il percorso dei tubi. Finché l’ora scade e finalmente puoi allontanarti da quello strazio. Non vedi l’ora di arrivare e non vedi l’ora di andartene.
C’è chi ha lo stomaco per stare a sentire il rapporto copia conforme dei medici che ti chiamano ogni giorno per fare il punto della situazione. C’è chi dice “anche no, non ditemi tutto per favore”. Cominci ad andare in fibrillazione due ore prima l’appuntamento telefonico (ma l’orario è sempre incerto) e dopo puoi lasciarti andare. A che cosa, dipende dalla notizia del giorno: “stazionario” è una grande notizia, significa che per oggi non muore.
Poi le cose “migliorano”, si cambia reparto e lì ti confronti con le storie degli altri, anzi, delle altre. Ognuna ha maturato un suo vizio, qualcosa che la stordisse. C’è chi non ha dormito per mesi, chi invece c’è riuscito benissimo specie dopo ore di pianto, chi passa l’aspirapolvere alle 5 del mattino, chi si fa il cicchetto tutte le sere. Ogni attività viene congelata, o si congela da sé. Un’ora di concentrazione su qualcosa è il massimo che ho raggiunto, in tutta la giornata.
E poi c’è quello che tu, caregiver, anche se stai solo assistendo e non stai offrendo nessuna cura, c’è quello che tu non vuoi sentirti dire, ma che per evitare conflitti diplomatici lasci dire. Insospettabili conoscenze mediche da insospettabili persone. Un esercizio del conforto (altrui) che ha il solo effetto di istigarti a delinquere. Spesso le parole sono soltanto rumore. Il dolore invece non vuole distrazioni. Lo devi attraversare tutto per non fartene inghiottire.
Infine ci sono loro. I medici, gli infermieri, gli oss. Uno spaccato di umanità.
C’è il medico che ti guarda e se ne sta dritto e fermo davanti a te, occupandosi solo di te e del tuo parente, t’invita pure a fare domande e ti chiede se hai capito tutto. C’è chi sembra stia per spiccare il volo come fosse ai nastri di partenza e ti scarica addosso un bignami di medicina mentre a te restano brandelli di informazione.
C’è l’infermiere che arriva senza che lo chiami e quello che arriva dopo un’ora e dopo che l’hai chiamato tre volte (tu paziente, non tu parente – il che è più frustrante, per il paziente). In quest’ultimo caso devi farti una botta di conti: saranno una dozzina di pazienti in reparto, tre so per certo che devono essere imboccati (se mangiano, benedetto sia il sondino!), c’è una flebo che deve essere sostituita, qualcuno che ha bisogno dell’insulina, un altro aspetta di essere ripulito dalla merda, a un altro è scivolato il cellulare e a qualcun altro il numero invece glielo devi fare e gli devi pure tenere il telefono. Qui non siamo più in terapia intensiva, sei in purgatorio, nella terra di mezzo prima di raggiungere la riabilitazione (la terra promessa!). Infermieri circa 3.
Ho conosciuto medici che il Covid l’hanno avuto, con tutti i crismi: fame d’aria, intubazione, allucinazioni post risveglio, riabilitazione.
Ho visto appannarsi gli occhi di medici e infermieri quando mi hanno detto di aver perso colleghi, o di colleghi che non potevano più esercitare, non ancora almeno.
Ho sentito medici lasciarsi andare all’ammissione che a casa, sul divano, i piedi gli bruciavano e il suono delle macchine e degli allarmi li accompagnava per tutta la notte, quando non era il sottofondo costante persino alle grida dei figli.
Ho visto medici e infermieri che la morte l’avevano scolpita negli occhi perché ne hanno visti tanti morire, non uno, non l’amico o il parente, decine e decine di sconosciuti, e questo in un solo reparto in un solo nosocomio di una sola città. Molti invece sono riusciti a traghettarli a una vita che non si sa ancora come sarà (neanche quando ti dimettono puoi fare ancora la conta dei danni).
Questa è una storia che nessuno vuole sentire e che tutti credono di conoscere o di saperne abbastanza. Per chi l’ha vissuta è come essere sopravvissuti al campo di concentramento: nessuno ha voglia di ascoltarti, nessuno vuole ascoltare veramente. In verità sei tu che non hai voglia di parlarne. Il dolore ha un suo pudore, vuole discrezione, esige silenzio. Così alla fine sei tu che fai silenzio.
C’è chi ha viaggiato moltissimo. Io però sono andata molto più lontano.
Contributo di Donatella Milano